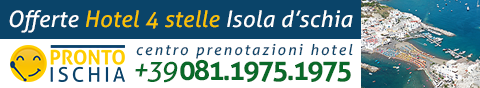Basta allontanarsi di pochi chilometri da Bratislava per trovarsi immersi in un paesaggio di colline, vigneti, rovine medievali e fortezze rinascimentali. A poco più di dieci chilometri dal centro, ad esempio, il Castello di Devín rappresenta probabilmente l’escursione più immediata, tanto che non sono pochi quelli che scelgono di raggiungerlo anche a piedi, seguendo il corso del Danubio per circa un’ora. Arroccato su uno sperone roccioso alla confluenza tra Danubio e Morava, il castello domina uno dei punti geograficamente e simbolicamente più densi di storia dell’Europa centrale. Qui correva il limes romano; qui si sono sovrapposte culture, eserciti e confini. Le rovine, più che riferirsi a un’unica epoca, restituiscono così l’idea di un luogo-soglia, posto tra Occidente e Oriente, tra mondo germanico e mondo slavo. Dall’alto, il panorama ampio e suggestivo rende immediatamente percepibile quanto la posizione fosse strategica. Spostandosi verso nord-est, a circa mezz’ora di strada, si entra invece nei Piccoli Carpazi, una regione che cambia completamente ritmo. Modra, con le sue case basse e il centro raccolto, è una tappa ideale per intercettare un volto più tradizionale della Slovacchia. L’area è nota per la produzione vinicola e per le ceramiche decorative, ma più in generale per un’atmosfera pacata, fatta di cantine, colline e strade secondarie. La cosiddetta Strada del Vino dei Piccoli Carpazi non è tanto un itinerario da seguire rigidamente quanto una traccia culturale che attraversa piccoli villaggi, degustazioni informali e un paesaggio che invita costantemente a rallentare. Infine, ma non per importanza, il Castello di Červený Kameň, a circa quarantacinque chilometri da Bratislava: una fortezza rinascimentale imponente, legata alle grandi famiglie nobiliari dell’Europa centrale, concepita sì per scopi difensivi, ma anche per impressionare, complice l’inserimento scenografico nel paesaggio collinare. Nel complesso, i dintorni di Bratislava non andrebbero pensati come semplici “aggiunte” al viaggio, bensì come parte integrante dell’esperienza. Castelli, vino e paesaggio contribuiscono a dare profondità a una città che vive in costante dialogo con il territorio che la circonda.